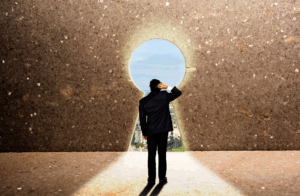L’introduzione del correttivo-bis (D.lgs. 81/2025) sta generando nuove incertezze e ostacoli normativi per i liberi professionisti che operano all’interno di strutture associative o società professionali, pur mantenendo una partita IVA personale. Le disposizioni, operative a partire dalle dichiarazioni dei redditi 2024, incidono direttamente sulla possibilità di adesione al Concordato Preventivo Biennale (CPB) per il periodo 2025-2026.
Una norma pensata per rafforzare le misure antielusive rischia, nei fatti, di complicare l’accesso allo strumento proprio da parte dei soggetti che, nel primo biennio 2024/2025, avevano mostrato la maggiore disponibilità a partecipare.
Un settore virtuoso ora penalizzato
Secondo i dati Sogei, nel primo biennio del concordato, il settore delle libere professioni aveva fatto registrare la più alta percentuale di adesione al CPB (circa il 20%), superando gli altri comparti economici. Tuttavia, le nuove regole introdotte dal correttivo-bis rischiano ora di rallentare o persino inibire la partecipazione a chi opera in forme organizzative più evolute.
La nuova disciplina prevede, infatti, ulteriori cause di esclusione e cessazione dal CPB nei casi in cui il professionista faccia parte di un’associazione professionale, una società tra professionisti o una società tra avvocati. Le conseguenze sono rilevanti sotto diversi profili:
- Disallineamento tra singoli e struttura
In molte realtà, si verificano situazioni di adesione non omogenea al CPB tra singoli professionisti e la struttura associativa: ad esempio, uno studio può aver aderito al concordato per il biennio 2024/2025, ma uno o più soci possono aver deciso di non farlo individualmente, o viceversa. Con il correttivo-bis, l’adesione per il biennio 2025/2026 di uno solo tra i due soggetti (singolo o struttura) determina, di fatto, un obbligo implicito anche per l’altro di aderire nel biennio successivo, a causa della nuova logica di “adesione vincolata di gruppo”.
Si crea così una situazione potenzialmente conflittuale, in cui le scelte autonome vengono compresse a vantaggio di una rigidità normativa difficile da gestire nella prassi operativa.
- Partite IVA individuali e punteggi ISA penalizzanti
Un’altra anomalia introdotta dal correttivo riguarda la valutazione della posizione fiscale individuale dei professionisti all’interno delle strutture. Molti di essi, pur operando prevalentemente nello studio associato, mantengono una partita IVA personale per gestire incarichi occasionali o attività specialistiche.
In questi casi, il punteggio ISA può risultare artificialmente basso, soprattutto nei casi di anzianità professionale elevata, mancanza di continuità nella fatturazione individuale o incassi disallineati. La conseguenza è che il fisco può formulare proposte di concordato al rialzo, del tutto non convenienti per il professionista, che quindi rinuncerà ad aderire.
- Il rischio della regola “simul stabunt simul cadent”
La disposizione che prevede l’esclusione automatica dal CPB dell’intera struttura associativa nel caso di fuoriuscita anche di un solo componente richiama il principio civilistico del “simul stabunt simul cadent” tipico dei consigli di amministrazione: se uno decade, decadono tutti.
Tuttavia, applicare questa logica all’universo delle professioni appare inappropriato e pericolosamente rigido. Gli studi professionali, pur operando in forma collettiva, restano sommatoria di soggetti autonomi, ognuno con posizioni fiscali, dinamiche economiche e scelte strategiche diverse. Forzare una logica di co-obbligazione solidale può disincentivare l’adesione al CPB da parte di interi gruppi di professionisti, per timore di penalizzazioni reciproche.
Una norma che contraddice lo spirito del concordato
Lo spirito originario del CPB era quello di stabilizzare il rapporto tra contribuente e fisco, introducendo un criterio previsionale basato su collaborazione, trasparenza e semplificazione. Le novità introdotte dal correttivo-bis rischiano di tradire questa impostazione, trasformando lo strumento in un meccanismo opaco, vincolante e rischioso per chi opera in forma organizzata.
Inoltre, si introduce una disparità di trattamento tra professionisti che esercitano individualmente e quelli che hanno scelto di lavorare in forma aggregata, premiando di fatto strutture meno efficienti e scoraggiando l’evoluzione naturale della professione verso modelli più collaborativi e performanti.
In un contesto in cui la fiscalità dovrebbe accompagnare l’innovazione e la modernizzazione del lavoro professionale, il correttivo-bis rischia di andare nella direzione opposta. È necessario, almeno in sede applicativa o interpretativa, un riequilibrio che tenga conto delle reali dinamiche del mondo professionale associato.
FISAPI, in rappresentanza delle istanze dei professionisti, continuerà a promuovere un confronto costruttivo con le istituzioni per garantire regole eque, flessibili e coerenti con la realtà del lavoro autonomo e associato.